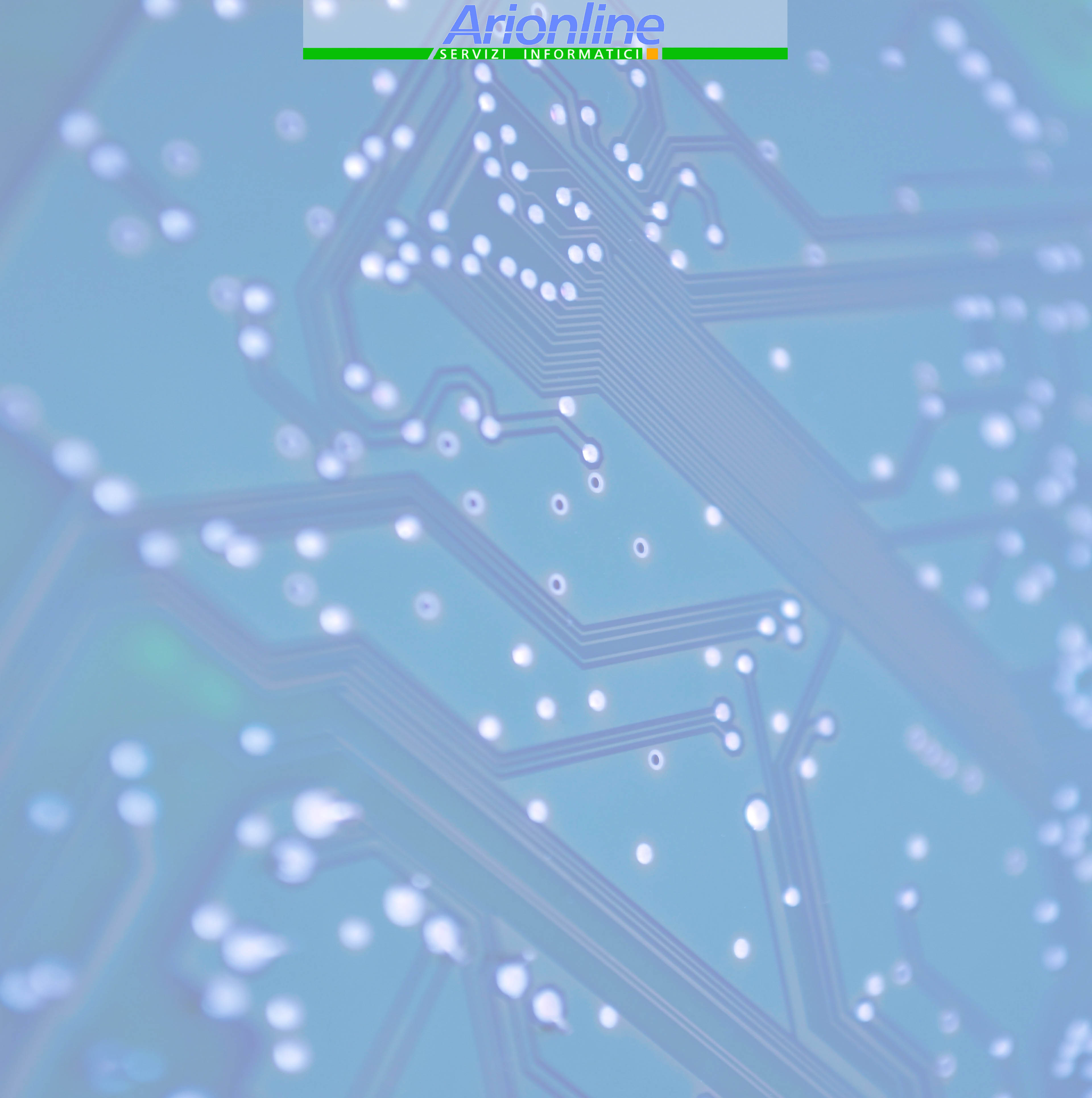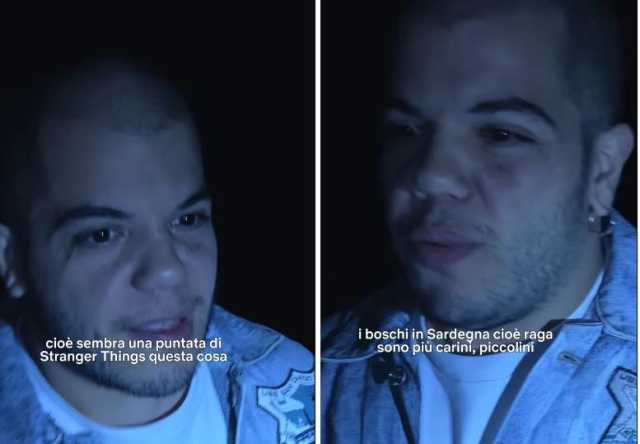È il 1921 e il ragazzo che piange davanti alla lettera che ha appena letto si chiama Mario Sturani, frequenta il ginnasio del liceo Cavour di Torino, e diventerà uno dei più grandi ceramisti del ventesimo secolo.
Chi l’ha scritta, quella lettera, è un suo caro amico, giovanissimo come lui, ma ha dentro già tanti tormenti, tutti grandi, riescono quasi a riempirgli l’anima. E si firma in modo veloce, tirando in avanti il tratto della e che gli chiude il nome e pure il cognome: Cesare. Pavese.
In quello stesso anno, Davide Lajolo, scrittore e politico, è al secondo anno di collegio dei Salesiani a Castelnuovo. E questo nome non gli dice niente. Non ancora, almeno. Gli dirà qualcosa da grande, quando diventeranno amici veri, amici intimi.
Sia Sturani che Lajolo, in momenti diversi della loro vista e della vita di Pavese, hanno conosciuto il suo “vizio assurdo”, quella radicata inclinazione alla morte che, se inquietava Sturani già nelle lettere del liceo, colpisce Lajolo tanto da sceglierla come titolo di una delle biografie più vere e struggenti della letteratura italiana. Un “vizio” che, settantuno anni fa, ha portato via un genio assoluto della letteratura e un uomo non solo, ma affetto da solitudine. Per questo si libera, per questo evade. Perchè quel vuoto gli fa troppo male. Perchè quel vuoto non lo sa riempire.
Cesare nasce nelle Langhe, a Santo Stefano Bembo, l’unico posto dove riuscirà a ritrovare la forza di vivere, come se appartenesse a quelle colline. Impara a soffrire da piccolo: a sei anni, ha già perso padre e tre fratelli e sua madre, che ha la forza di reagire alle sferzate del destino e di fare turni di lavoro da stakanovista pur di mandare avanti la famiglia, è una donna aspra, segnata dal dolore, che non lo abbraccia mai. Pavese implode piano, senza l’affetto che merita un bambino, creando un legame fortissimo, quasi pascoliano, con quella campagna e col suo paese. Ammira il gesto di un compagno di scuola, che si è tolto la vita con un colpo di pistola. Scrive di averci provato anche lui, con una rivoltella. Gattona sulle orme di Gobetti e di Monti e la fase partigiana la riflette nel Pablo de “Il compagno” che, dopo essere maturato, combatte per un domani migliore, ma quella stessa prospettiva, dentro Pavese, si incupisce anno dopo anno. La letteratura e la scrittura, per lui, diventano indispensabili: si avvicina alla produzione inglese e americana, adora Melville.
Entra in Einaudi, che pubblica “Lavorare stanca” mentre lui è dietro le sbarre per antifascismo, sorte che non avranno molti suoi compagni torinesi, uccisi. L’amore per Costance Dowling gli logora il cuore, già segnato da un radicato complesso nei confronti del sesso femminile che lo ha sempre limitato nelle interazioni sociali.
Torino lo estranea sempre di più, la campagna lo libera. Ed è lì che torna, come Anguilla, per scrivere il suo capolavoro, “La luna e i falò”. Ed è lì che, come lui, comprende davvero cosa sia il tempo, parlando con Nuto e rendendo vivi i ricordi di paese: un grandioso e potente dialogo con se stesso. Forse, per ritrovarsi. Neanche il Premio Strega riesce a non fargli ingerire la decina di bustine di sonnifero che lo addormentano per sempre in una camera d’albergo. “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”, lascerà scritto, in penna nera, sul tavolino della stanza.
Lajolo è il primo ad avere l’onore di aprire il baule delle lettere di Pavese, anche se molte di quelle che utilizzerà gli verranno fornite da Sturani o da Fernanda Pivano. E a scrivere di un autore e di una persona fuori dall’ordinario, razionale ed emotiva, ma sempre reale e sospesa fra “pietà di sé e paura”. “Ora non scriverò più e farò il mio viaggio nel regno dei morti. Ciao per sempre. Cesare”, scrive Pavese a Lajolo. Allungando con il pennino la e che gli chiude il nome e il cognome. E lo saluta come può fare solo lui. Con poco rumore. Con tanto dolore.
- Matteo Porru